La tutela della modularità nel settore arredo
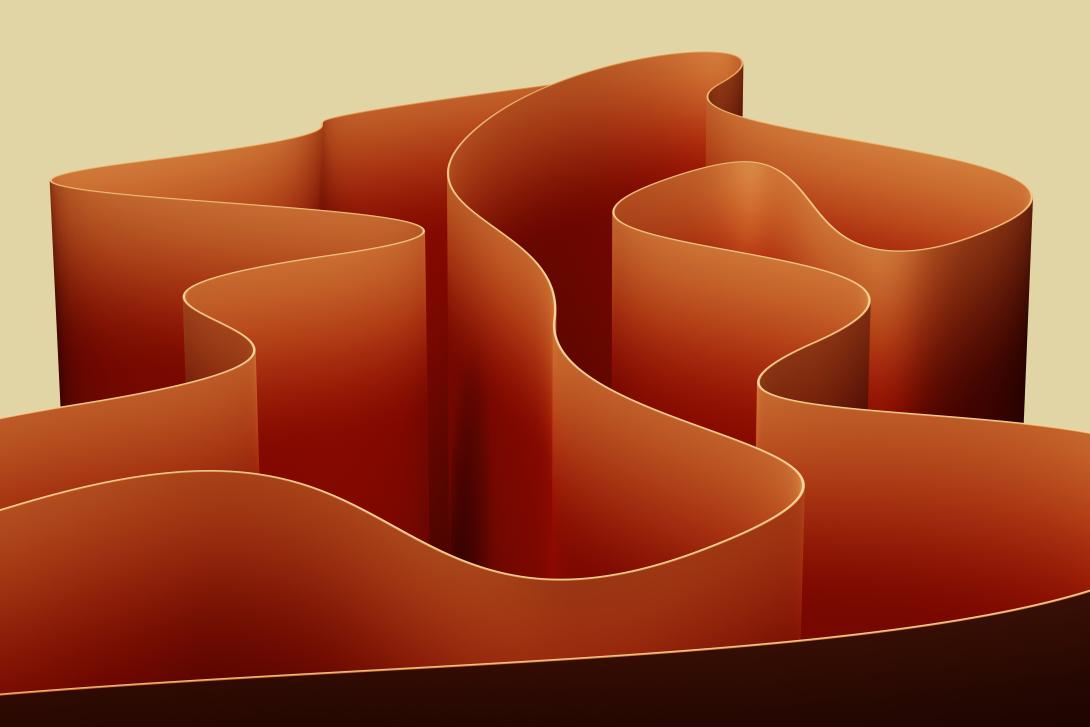
La modularità (intesa come la suddivisione di un prodotto in componenti indipendenti e intercambiabili, che possono essere combinati, spostati o sostituiti per creare varie configurazioni e rispondere a esigenze mutevoli) è oggi protagonista dei più svariati campi, inclusi quelli dell’architettura e del mondo dell’arredo. Ogni anno al pubblico vengono presentati moduli che compongono luci, cucine, imbottiti e scaffalature, destinati a essere declinati in molteplici soluzioni. Il sistema modulare, che è stato definito il “design del futuro”, infatti, grazie alle sue caratteristiche insite, quali la versatilità, la riconfigurabilità, la flessibilità, la riciclabilità e la riutilizzabilità nel tempo, risponde alle sempre più stringenti esigenze sia del pubblico, sia delle norme in materia di sostenibilità, cui tutti gli operatori del mercato sono chiamati ad adeguarsi. Essere consapevoli degli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per la sua tutelabilità è dunque quanto mai opportuno. Qui di seguito, in particolare, ci concentreremo sulle norme in punto di disegni e modelli e di concorrenza sleale, in quanto comprendere le loro sottili sfaccettature risulta essenziale per garantire al modulo una protezione avveduta e market-oriented.
- La modularità: il design del futuro
Caratterizzato da una struttura flessibile, adattabile ad ogni contesto, riconfigurabile e personalizzabile, il sistema modulare – e cioè quel sistema che si compone di plurimi elementi (moduli, appunto) che “sono destinati a combinarsi e collegarsi fra loro reciprocamente per dare vita ad un prodotto complesso”, declinato in molteplici combinazioni – è stato definito il “design del futuro, del risparmio, del riciclo”, al punto che la sua “diffusione radicale” è stata pronosticata come “inevitabile”: e, infatti, esso è oggi il protagonista dei più svariati settori, dalla meccanica all’elettronica, dal mondo dei giochi all’edilizia, dall’architettura al mondo dell’arredo.
I vantaggi di tale tipo di sistema sono molteplici: per citarne alcuni, la riduzione dei tempi di progettazione e la possibilità di progettare in parallelo i diversi moduli, con risparmio di costi e risorse; gli investimenti mirati su di un singolo modulo, poi declinabile potenzialmente all’infinito, con anche conseguente aumento della gamma dei prodotti disponibili; l’ estrema personalizzabilità della composizione modulare, paradossalmente garantita dalla natura standard dei singoli moduli; la modificabilità continua del prodotto modulare acquistato e la garanzia della sua manutenzione e sostituzione.
Non da ultimo, la sostenibilità. Gli operatori che adottano i sistemi modulari sono tutti concordi nell’evidenziare che “la costruzione modulare è per definizione un concetto sostenibile”, proprio in forza delle sue caratteristiche insite, a cominciare dalla riutilizzabilità e riciclabilità, che garantiscono – oltre che risparmio di tempi e costi, e versatilità – anche il rispetto dei più stringenti canoni di efficienza ecologica e ambientale e, in senso lato, dell’Economia Circolare. Per fare un esempio, si pensi che nel mondo dell’edilizia e dell’architettura si è rilevato che la costruzione modulare consente un risparmio di materiale dal 30% al 60% rispetto ai metodi di costruzione convenzionali, con conseguente rilevante riduzione delle emissioni di CO2 nell’ambiente[1].
Come detto, le potenzialità della modularità, specie sotto il profilo sostenibile, sono state colte nella loro essenzialità anche dal mondo del design e dell’arredo. Ogni anno al pubblico vengono presentati moduli che compongono scaffalature, armadi, imbottiti, luci e cucine, destinati a collegarsi per poi dividersi, affiancarsi per poi separarsi, in un continuo movimento fluido che supera la tradizionale rigidità dell’elemento, dello spazio e del tempo.
In tale contesto, è quindi quanto mai opportuno capire e conoscere se, e come, tutelare la modularità.
- La tutelabilità dei sistemi modulari come disegni e modelli
La rilevanza commerciale dei sistemi modulari è stata colta e recepita sin dalla Direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998 sulla protezione dei disegni e modelli, che, infatti, ai considerando nn. 14 e 15 se, da un lato, prevedeva che “l'interfunzionalità di prodotti di differenti fabbricazioni non dovrebbe essere ostacolata estendendo la protezione al disegno o modello delle connessioni meccaniche”, dall’altro, statuiva che “tuttavia, le connessioni meccaniche dei prodotti modulari possono costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un punto di forza sotto il profilo commerciale e … dovrebbero pertanto essere ammesse alla protezione”: con ciò esplicitando che, a differenza delle interconnessioni (ovvero, le caratteristiche formali che consentono al prodotto di essere connesso con un altro), infatti escluse dalla tutela del design, anche per evitare il sorgere di monopoli, i sistemi modulari avrebbero potuto invece costituire un valido disegno e modello, ovviamente se dotati dei necessari requisiti di tutela, e cioè novità e carattere individuale, proprio in quanto essi stessi avrebbero potuto attribuire forza commerciale al prodotto.
L’art. 7, comma 3, della detta Direttiva CE, pertanto, introducendo una deroga alla libera riproducibilità delle forme relative alle interconnessioni, stabiliva che “il disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 4 e 5” – ovvero, come detto, di novità e di carattere individuale – “è protetto quando ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare”.
Tale approccio (anche market-oriented) è stato poi ripreso, e dunque confermato, dalla recente Direttiva (UE) 2024/2823 del 23 ottobre 2024, facente parte insieme al Regolamento (UE) 2024/2822 di pari data, del c.d. “Design Pack”, che, infatti ha mantenuto invariato il citato articolo 7, di nuovo in forza del considerando (in questo caso, il n. 21) per cui “le connessioni meccaniche dei prodotti modulari possono costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un punto di forza sotto il profilo commerciale e dovrebbero pertanto essere ammesse alla protezione”.
Naturalmente, anche il Regolamento sui disegni e modelli comunitari n. 6/2002 del 12 dicembre 2001, anche nella sua più recente versione contenuta nel citato Regolamento (UE) 2024/2822, contiene una previsione del tutto analoga a quella di cui all’art. 7, comma 3, della Direttiva, all’art. 8, comma 3.
Allo stesso modo, anche il Codice della Proprietà industriale, all’art. 36, comma 2, pone una deroga alla non tutelabilità come disegni e modelli delle forme di interconnessione “quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare”, fermi – ovviamente – i requisiti di novità e carattere individuale.
La dottrina[2] ha evidenziato che la deroga in favore della modularità troverebbe la ratio nel fatto che, a differenza che nel settore delle interconnessioni, dove coinvolti risulterebbero almeno due prodotti, con la conseguenza che l’attribuzione di una privativa al produttore del bene cui connettersi consentirebbe a questi l’influenza sul mercato del bene da connettere, i prodotti modulari si traducono invece in un unico prodotto: e questo avrebbe fatto scaturire l’esigenza di evitare che i concorrenti, mediante la riproduzione della particolare forma di interconnessione (il modulo, appunto) potessero beneficiare di quella che è stata definita una “comoda scorciatoia per entrare in un mercato particolare in cui il carattere innovativo dei disegni e dei modelli in questione è spesso costituito … dal disegno di elementi che consentono interconnessioni infinite con gli elementi del sistema”.
Per beneficiare delle protezione in parola, occorre quindi anzitutto escludere che il prodotto (e cioè il modulo) non si limiti a consentire l’unione meccanica di diversi prodotti, in modo tale che uno, o entrambi, possano svolgere la loro funzione (si pensi, ad esempio, al meccanismo di aggancio di un tubo per aspirapolvere all’aspirapolvere stesso): nel qual caso, infatti, si rientrerebbe nell’ambito di applicazione della regola generale del divieto di esclusiva per le forme di mera interconnessione; e all’opposto positivamente concludere che esso presenti questi tre specifici requisiti: a) l’intercambiabilità (possibilità di sostituire un pezzo con l’altro nel sistema di interconnessione multipla), b) l’unione multipla (la possibilità di scelta per l’utente fra più possibili connessioni), c) la componibilità dei singoli prodotti/moduli in un unico sistema, appunto modulare.
A quel punto, soddisfatte queste condizioni, dovranno venire verificate la sussistenza dei requisiti di novità e carattere individuale e, al contempo, l’assenza di impedimenti assoluti alla registrazione, e in particolare che oggetto della aspirata esclusiva non siano le “ caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso”, infatti escluse dalla protezione come disegno e modello dall’art. 36, comma 1.
Sul punto, segnaliamo una recente pronuncia del Tribunale dell’Unione Europea che ha confermato la validità del modello del mattoncino della Lego proprio in forza della sua natura (anche) modulare (T-537/22 del 24 gennaio 2024). Senza entrare nel dettaglio del caso di specie, ciò che rileva è che il Tribunale ha spiegato che “un disegno o modello può essere dichiarato nullo, ai sensi di tale articolo [cioè dell’art. 8 del Reg. CE n. 6/2002], solo nel caso in cui tutte le sue caratteristiche rientrino nell’ambito di applicazione di tale articolo, il che implica, da un lato, che esse soddisfino i requisiti previsti da tale articolo e, dall’altro, che nessuna di esse rientri nell’eccezione prevista dall’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento”, ovvero quella sulla modularità, con la conseguenza che “un disegno o modello è dichiarato nullo, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 6/2002, solo nel caso in cui tutte le sue caratteristiche siano escluse dalla protezione. Se almeno una delle sue caratteristiche è protetta, in particolare in virtù dell’applicazione dell’eccezione prevista dall’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, il disegno o modello rimane valido”: ciò significa che, al fine del deposito di un disegno o modello relativo a un modulo, e più in generale a delle connessioni modulari, occorre effettuare ex ante una valutazione di ciò che può essere considerato estetico e/o tecnico, e, in questo (solo) secondo caso se vi sono gli estremi per beneficiare comunque della deroga sulla modularità, proprio al fine di vantare un valido diritto di esclusiva.
La comprensione della portata dell’eccezione in parola, dunque, si conferma, anche alla luce di questa recente pronuncia, essenziale sia per la tutela dei proprio diritti, anche in difesa, sia in un’ottica di mercato, per valorizzare il prodotto che abbiamo visto essere oggi al centro dei più diversi settori proprio grazie alle sue peculiari caratteristiche.
- La protezione dei sistemi modulari anche tramite le disposizioni in materia di concorrenza sleale
Come abbiamo accennato prima, la ratio sottesa alla garanzia di tutela dei moduli risiede nel fatto che l’elemento del sistema modulare è esso stesso il prodotto, con la conseguenza che una esclusiva ad esso relativa non si tradurrebbe in un (rischio di) monopolio. Anzi – come ha rilevato la dottrina – “chi produce elementi di un sistema modulare con il sistema altrui sarebbe allo stesso modo in grado di produrre un’autonoma serie con caratteristiche proprie”. Partendo da queste premesse e declinate in punto di concorrenza, pertanto, la Suprema Corte aveva statuito che, se non poteva tradursi in concorrenza sleale la funzione della reciproca compatibilità tra prodotti “realizzata dal concorrente in una analoga serie componibile”, tuttavia lo era la messa in commercio di prodotti compatibili con quelli del concorrente “perché ciò, contrariamente alla logica del divieto di concorrenza sleale, gli consentirebbe di avvantaggiarsi, oltre che della idea alla base del sistema modulare altrui, anche di quanto, sfruttando quella idea, il concorrente è riuscito a conseguire in termini di avviamento” (C. civ., Sez. I, 9.3.1998, n. 2578): la Cassazione, dunque, inquadrava la fattispecie nella previsione di cui all’art. 2598, n. 3, c.c. e quindi nella ‘‘clausola generale’’ che fa divieto al concorrente del “vale(rsi) direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”. Anche la giurisprudenza di merito, più di recente, ha ribadito che la commercializzazione di prodotti modulari compatibili con quelli di un concorrente in mancanza di una giustificazione (in termini di costi e funzionalità dei prodotti) costituisce un’ipotesi di concorrenza sleale per violazione dei principi di correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 (App. Mi, 28.10.2003).
Nel senso dell’illiceità dell’adozione del medesimo sistema di connessione modulare da parte del concorrente anche ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c., che vieta l’imitazione confusoria di forme dotate di capacità distintiva, si era espresso il Tribunale di Torino, che aveva affermato che “costituisce atto di concorrenza sleale per imitazione servile di un sistema modulare di mattoncini per giochi di costruzione l’adozione del medesimo sistema di connessione meccanica, determinato da elementi di identica misura, in quanto il consumatore può ritenere che quegli elementi facciano parte del gioco imitato, in quanto combinabili con esse, provenendo dal medesimo produttore” (T. To, 15.3.2001); tuttavia questa posizione è stata ribaltata dalla Suprema Corte nel 2008, la quale infatti ha invece ritenuto che “In tema di concorrenza sleale, la produzione di elementi modulari compatibili con quelli già in distribuzione da parte di impresa concorrente non integra un comportamento idoneo a creare confusione sulla loro provenienza, perché l’interconnettività fra sistemi modulari compatibili rappresenta un’utilità che giustifica pienamente la concorrenziale e millimetrica riproduzione degli elementi di connessione rientrando nella categoria delle forme funzionali all’uso del prodotto”, spiegando anche che “anche un variante soltanto millimetrica degli elementi modulari non risulterebbe innocua”, essendo evidente che se si precludesse la compatibilità tra sistemi modulari di diversa produzione “il produttore che abbia goduto in passato di un diritto di esclusiva procrastinerebbe gli effetti nel mercato degli elementi modulari integrativi” (Cass, 28.2.2008, n. 5437). Non senza dire che, affinché si possa ricorrere a questa fattispecie, occorre che il prodotto abbia acquisito la capacità distintiva, il che tuttavia si porrebbe in contrasto con la previsione per cui oggetto di valido marchio non possono essere quelle forme necessarie per ottenere un risultato tecnico, che nel caso delle interconnessioni, anche modulari, è senz’altro presente. E, infatti, la Corte di Giustizia, sempre in uno dei casi Lego, pur avendo rilevato che il mattoncino aveva nel tempo acquisito capacità distintiva, tuttavia non poteva accedere per tali ragioni alla tutela come marchio (C. Giust. UE, 14.9.2010, C-48/09).
Ad oggi, dunque, la via immediata per impedire atti concorrenzialmente illeciti di terzi concorrenti pare ancora essere quella di cui alla citata “clausola generale” dell’art. 2598, n. 3, c.c.
[1] https://academy.tecnostrutture.eu/, e https://www.rinnovabili.it/green-building/building/green-building-il-nuovo-trend-delledilizia/
[2] Sul punto si vedano, la Relazione alla proposta di regolamento sul modello comunitario, in RDI, 1994, III, 225; Galli, L’attuazione della Direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, in NLCC, 2001, 894; e Frassi, Imitazione servile e prodotti modulari, in RDI, 1998, II, 269 ss.
Keywords